
Una vergogna. Anzi:un’infamia.

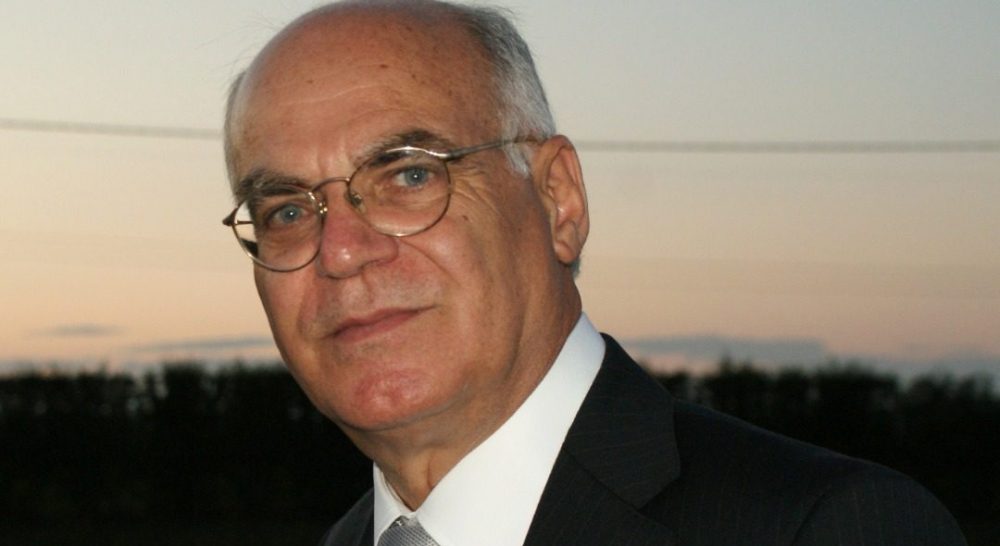

Il significato storico e simbolico di SA DIE DE SA SARDIGNA
di Francesco Casula
“Firmaisì! E arrazza de brigungia! Arrazza ‘e onori! Sardus, genti de onori! E it’ant a nai de nosus, de totus ! Chi nc’eus bogau s’istrangiu po amori ‘e libertadi ? Nossi, po amori de s’arroba! Lassai stai totu! Non toccheis nudda! Non ddi faeus nudda de sa merda de is istrangius! Chi ddi sa pappint a Torinu cun saludi! A nosus interessat a essi meris in domu nostra! Libertadi, traballu, autonomia!”
Nella divertente e brillante finzione letteraria e teatrale, in “Sa dì de s’acciappa” lo scrittore Piero Marcialis (1) fa dire così a Francesco Leccis, – beccaio, protagonista della rivolta cagliaritana contro i Piemontesi – rivolgendosi ai popolani che, infuriati volevano assaltare i carri, zeppi di ogni ben di dio, per sottrarre ai dominatori in fuga “s’arroba” che volevano portarsi a Torino.
Ed è questo – a mio parere – il significato profondo, storico e simbolico, della cacciata dei Piemontesi da Cagliari il 28 Aprile 1794: i Sardi, dopo secoli di rassegnazione, di abitudine a curvare la schiena, di acquiescenza, di obbedienza, di asservimento e di inerzia, per troppo tempo usi a piegare il capo, subendo ogni genere di soprusi, umiliazioni, sfruttamento e sberleffi, con un moto di orgoglio nazionale e un colpo di reni, di dignità e di fierezza, si ribellano e alzano il capo, raddrizzano la schiena e dicono: basta! In nome dell’Autonomia e dunque, per “essi meris in domu nostra”.
E cacciano i Piemontesi, i Nizzardi e i Savoiardi, non per motivi etnici, ma perché rappresentano l’arroganza, la prepotenza e il potere: 600-620 secondo lo storico Luciano Carta, 514 secondo Girolamo Sotgiu e Raimondo Carta Raspi: comunque moltissimi, una burocrazia politico-militare e parassitaria vastissima. Tenendo presente che Cagliari agli inizi dell’800 aveva 20.000 abitanti, vi era più di un “burocrate” e “parassita” piemontese ogni 40 abitanti!
Si è detto e scritto che si è trattato di “robetta”: di una semplice congiura ordita da un manipolo di borghesi giacobini, illuminati e illuministi, per cacciare qualche centinaio di piemontesi. Non siamo d’accordo.
A questa tesi, del resto ha risposto, con dovizia di dati, documenti e argomentazioni, Girolamo Sotgiu (2).
Il prestigioso storico sardo, gran conoscitore e studioso della Sardegna sabauda, polemizza garbatamente ma decisamente proprio con l’interpretazione data da storici come il Manno o l’Angius al 28 Aprile, considerato alla stregua, appunto, di una congiura.
Simile interpretazione offusca – a parere di Sotgiu – le componenti politiche e sociali e, bisogna aggiungere senza temere di usare questa parola «nazionali».
Insistere sulla congiura – cito sempre lo storico sardo – potrebbe alimentare l’opinione sbagliata che l’insurrezione sia stato il risultato di un intrigo ordito da un gruppo di ambiziosi, i quali stimolati dagli errori del governo e dalle sollecitazioni che venivano dalla Francia, cercò di trascinare il popolo su un terreno che non era suo naturale, di fedeltà al re e alle istituzioni.
A parere di Sotgiu questo modo di concepire una vicenda complessa e ricca di suggestioni, non consente di cogliere il reale sviluppo dello scontro sociale e politico né di comprendere la carica rivoluzionaria che animava larghi strati della popolazione di Cagliari e dell’Isola nel momento in cui insorge contro coloro che avevano dominato da oltre 70 anni.
Non fu quindi congiura o improvviso ribellismo: ad annotarlo è anche Tommaso Napoli, padre scolopio, vivace e popolaresco scrittore ma anche attento e attendibile testimone, che visse quelli avvenimenti in prima persona.
Secondo il Napoli l’avversione della «Nazione Sarda» – la chiama proprio così – contro i Piemontesi, cominciò da più di mezzo secolo, allorché cominciarono a riservare a sé tutti gli impieghi lucrosi, a violare i privilegi antichissimi concessi ai Sardi dai re d’Aragona, a promuovere alle migliori mitre soggetti di loro nazione lasciando ai nazionali solo i vescovadi di Ales, Bosa e Castelsardo, ossia Ampurias.
L’arroganza e lo sprezzo – continua – con cui i Piemontesi trattavano i Sardi chiamandoli pezzenti, lordi, vigliacchi e altri simili irritanti epiteti e soprattutto l’usuale intercalare di Sardi molenti, vale a dire asinacci inaspriva giornalmente gli animi e a poco a poco li alienava da questa nazione.
Note Bibliografiche
1.Piero Marcialis, Sa dì de s’acciappa, Dramma storico in due tempi e sette quadri, editore Condaghes, Cagliari.
2.Girolamo Sotgiu, L’Insurrezione a Cagliari del 28 Aprile 1794, Editore,AM&D, Cagliari
Il significato storico e simbolico di SA DIE DE SA SARDIGNA
di Francesco Casula
“Firmaisì! E arrazza de brigungia! Arrazza ‘e onori! Sardus, genti de onori! E it’ant a nai de nosus, de totus ! Chi nc’eus bogau s’istrangiu po amori ‘e libertadi ? Nossi, po amori de s’arroba! Lassai stai totu! Non toccheis nudda! Non ddi faeus nudda de sa merda de is istrangius! Chi ddi sa pappint a Torinu cun saludi! A nosus interessat a essi meris in domu nostra! Libertadi, traballu, autonomia!”
Nella divertente e brillante finzione letteraria e teatrale, in “Sa dì de s’acciappa” lo scrittore Piero Marcialis (1) fa dire così a Francesco Leccis, – beccaio, protagonista della rivolta cagliaritana contro i Piemontesi – rivolgendosi ai popolani che, infuriati volevano assaltare i carri, zeppi di ogni ben di dio, per sottrarre ai dominatori in fuga “s’arroba” che volevano portarsi a Torino.
Ed è questo – a mio parere – il significato profondo, storico e simbolico, della cacciata dei Piemontesi da Cagliari il 28 Aprile 1794: i Sardi, dopo secoli di rassegnazione, di abitudine a curvare la schiena, di acquiescenza, di obbedienza, di asservimento e di inerzia, per troppo tempo usi a piegare il capo, subendo ogni genere di soprusi, umiliazioni, sfruttamento e sberleffi, con un moto di orgoglio nazionale e un colpo di reni, di dignità e di fierezza, si ribellano e alzano il capo, raddrizzano la schiena e dicono: basta! In nome dell’Autonomia e dunque, per “essi meris in domu nostra”.
E cacciano i Piemontesi, i Nizzardi e i Savoiardi, non per motivi etnici, ma perché rappresentano l’arroganza, la prepotenza e il potere: 600-620 secondo lo storico Luciano Carta, 514 secondo Girolamo Sotgiu e Raimondo Carta Raspi: comunque moltissimi, una burocrazia politico-militare e parassitaria vastissima. Tenendo presente che Cagliari agli inizi dell’800 aveva 20.000 abitanti, vi era più di un “burocrate” e “parassita” piemontese ogni 40 abitanti!
Si è detto e scritto che si è trattato di “robetta”: di una semplice congiura ordita da un manipolo di borghesi giacobini, illuminati e illuministi, per cacciare qualche centinaio di piemontesi. Non siamo d’accordo.
A questa tesi, del resto ha risposto, con dovizia di dati, documenti e argomentazioni, Girolamo Sotgiu (2).
Il prestigioso storico sardo, gran conoscitore e studioso della Sardegna sabauda, polemizza garbatamente ma decisamente proprio con l’interpretazione data da storici come il Manno o l’Angius al 28 Aprile, considerato alla stregua, appunto, di una congiura.
Simile interpretazione offusca – a parere di Sotgiu – le componenti politiche e sociali e, bisogna aggiungere senza temere di usare questa parola «nazionali».
Insistere sulla congiura – cito sempre lo storico sardo – potrebbe alimentare l’opinione sbagliata che l’insurrezione sia stato il risultato di un intrigo ordito da un gruppo di ambiziosi, i quali stimolati dagli errori del governo e dalle sollecitazioni che venivano dalla Francia, cercò di trascinare il popolo su un terreno che non era suo naturale, di fedeltà al re e alle istituzioni.
A parere di Sotgiu questo modo di concepire una vicenda complessa e ricca di suggestioni, non consente di cogliere il reale sviluppo dello scontro sociale e politico né di comprendere la carica rivoluzionaria che animava larghi strati della popolazione di Cagliari e dell’Isola nel momento in cui insorge contro coloro che avevano dominato da oltre 70 anni.
Non fu quindi congiura o improvviso ribellismo: ad annotarlo è anche Tommaso Napoli, padre scolopio, vivace e popolaresco scrittore ma anche attento e attendibile testimone, che visse quelli avvenimenti in prima persona.
Secondo il Napoli l’avversione della «Nazione Sarda» – la chiama proprio così – contro i Piemontesi, cominciò da più di mezzo secolo, allorché cominciarono a riservare a sé tutti gli impieghi lucrosi, a violare i privilegi antichissimi concessi ai Sardi dai re d’Aragona, a promuovere alle migliori mitre soggetti di loro nazione lasciando ai nazionali solo i vescovadi di Ales, Bosa e Castelsardo, ossia Ampurias.
L’arroganza e lo sprezzo – continua – con cui i Piemontesi trattavano i Sardi chiamandoli pezzenti, lordi, vigliacchi e altri simili irritanti epiteti e soprattutto l’usuale intercalare di Sardi molenti, vale a dire asinacci inaspriva giornalmente gli animi e a poco a poco li alienava da questa nazione.
Note Bibliografiche
1.Piero Marcialis, Sa dì de s’acciappa, Dramma storico in due tempi e sette quadri, editore Condaghes, Cagliari.
2.Girolamo Sotgiu, L’Insurrezione a Cagliari del 28 Aprile 1794, Editore,AM&D, Cagliari
Verso il 28 aprile: la Festa nazionale del popolo sardo
di Francesco Casula
Per ricordare lo scommiato dei Piemontesi è nata ”Sa Die, giornata del popolo sardo” –ma io preferisco chiamarla “Festa nazionale dei Sardi” – con la legge n.44 del 14 Settembre 1993. Con essa la Regione Autonoma della Sardegna ha voluto istituire una giornata del popolo sardo, da celebrarsi il 28 Aprile di ogni anno, in ricordo – dicevo – dell’insurrezione popolare del 28 Aprile del 1794, ovvero dei “Vespri sardi” che portarono all’espulsione da Cagliari e dall’Isola dei piemontesi e di altri forestieri ligi alla corte sabauda, compreso lo stesso inviso Viceré Balbiano.
Il problema che abbiamo oggi davanti, a livello soprattutto culturale, non è tanto quello di ridiscutere la data o, peggio, il valore stesso di una Festa nazionale sarda, bensì di non ridurla a semplice rito, a pura vacanza scolastica o a mero avvenimento folclorico e festaiolo.
Il problema è quello di trasformarla in una occasione di studio –soprattutto nelle scuole – della storia e della cultura sarda, di confronto e di discussione collettiva e popolare, per capire quello che siamo stati, quello che siamo e vogliamo essere; per difendere e sviluppare la nostra identità e la nostra coscienza di popolo e di nazione; per batterci per una Comunità moderna e sovrana, capace di mettere in campo l’orgoglio e il protagonismo dei Sardi, decisi finalmente a costruire un riscatto ovvero un futuro di prosperità e di benessere, lasciandosi alle spalle la rassegnazione, la lamentazione, il piagnisteo e i complessi di inferiorità e avendo il coraggio di “cacciare” i “nuovi piemontesi” o romani o milanesi che siano, non meno arroganti, prepotenti sfruttatori e “tiranni” di quelli scommiatati da Cagliari il 28 Aprile del 1794.
“Fu un momento esaltante – ha scritto Giovanni Lilliu – fu un’azione, poi bloccata dalla reazione “realista”, tesa a procurare un salto di qualità storica. Fu il tentativo di ottenere il passaggio da una Sardegna asservita al feudalesimo ad una Sardegna libera, fondando nell’autonomia, nel riscatto della coscienza e dell’identità di popolo una nuova patria sarda, una nazione protagonista”.
Al di là comunque di tutto questo e dello specifico avvenimento, quello che è importante è oggi il valore simbolico di autocoscienza storica e di forza unificante. Nessun ripiegamento nostalgico o risentito verso il passato dunque: ma il passato sepolto, nascosto, rimosso, si tratta prima di tutto di dissotterrarlo e conoscerlo, perché diventi fatto nuovo che interroga l’esperienza del tempo attuale, per affrontare il presente nella sua drammatica attualità, per definire un orizzonte di senso, per situarci e per abitare, aperti al suo respiro, il mondo lottando contro il tempo della dimenticanza. Un passato che – solo apparentemente perduto – occorre ritrovare perché è durata, eredità, coscienza. In esso si innesta infatti il valore dell’Identità, non statico e chiuso, non memoria cristallizzata ma patrimonio che viene da lontano e fondamento nel quale far calare nuovi apporti di culture, di vite individuali e sociali che determinano sempre nuove identità.
Il messaggio di Sa die è rivolto soprattutto ai giovani e l’occasione storico-culturale è destinata prima di tutto agli studenti, perché acquistino consapevolezza di appartenere a una storia e a una civiltà e di ereditare un patrimonio culturale, linguistico artistico e musicale, ricco di risorse da elaborare e confrontare con esperienze e proposte di un mondo più vasto e complesso. In cui, partendo da radici sicure e dotati di robuste ali, possano volare alti: i giovani e non solo.
QUALE 25 APRILE
di Francesco Casula
Per i morti, per tutti i morti non possiamo che nutrire e riversare tutta intera la nostra pietas. E la pietas cristiana da parte dei credenti.
Ma per favore senza metter sullo stesso piano oppressi e oppressori, vittime e carnefici; chi si batteva per la libertà e chi invece ce la voleva togliere ed eliminare.
Tener viva la memoria, la verità, significa ricordare a chi lo dimentica e a chi non l’ha mai saputo cos’è stato il fascismo, compreso il suo epilogo con la RSI (Repubblica sociale italiana di Salò): fu uno stato fondato sulla tortura, sulla persecuzione razziale e politica, sulla distruzione fisica degli avversari, sulla delazione: né sessanta né cento anni bastano a cancellare tutto questo.
Né basteranno per farci dimenticare i ben 900 campi di sterminio e di concentramento disseminati soprattutto in Germania e nell’Europa orientale ma anche in Italia (Fossoli, Bolzano, Trieste, Borgo San Dalmazzo-Cuneo), con milioni di innocenti sterminati.
Si dirà che è roba vecchia, consegnata ormai al passato remoto; che il fascismo è morto e dunque serve solo all’antifascismo per vivere di rendita, parassitariamente.
Può darsi.
Ma pensiamo veramente che siano morte e sepolte le coordinate ideologiche, culturali e persino economiche e sociali che hanno fatto nascere, alimentato e fatto crescere e vivere il fascismo? Pensiamo sul serio che la cultura – o meglio l’incultura – della guerra e della violenza, del sopruso e della sopraffazione, dell’esclusione e dell’intolleranza, dell’ipocrisia e del perbenismo, del servilismo e dell’informazione addomesticata e velinara, sia morta per sempre?
E gli inquietanti fenomeni – soprattutto giovanili – di rinascita e affermazione di Movimenti che si ispirano al nazifascismo? Roba vecchia anche questa o drammaticamente nuova e attuale?
Si dirà che comunque il Fascismo ha realizzato opere meritorie e importanti, ad iniziare dalla Sardegna: ma, di grazia, quali?
A tal proposito, ecco quanto sostiene nella sua bella e interessante “Storia della Sardegna” (pag.914) Raimondo Carta-Raspi :”Anche della Sardegna appariranno, in libri e riviste, descrizioni e fotografie delle ”opere del regime” durante il ventennio. Favole per l’oltremare, per chi non conosceva le condizioni dell’Isola. V’erano sempre incluse la diga del Tirso, già in potenza dal 1923, le Bonifiche d’Arborea, iniziate fin dal 1919 e perfino il Palazzo comunale di Cagliari, costruito nel 1927. Capolavoro del fascismo fu invece la creazione di Carbonia, per l’estrazione del carbone autarchico, che non doveva apportare alcun beneficio all’Isola e doveva costare centinaia di milioni e poi miliardi che tanto meglio si sarebbero potuti investire in Sardegna, anche per la trasformazione del Sulcis in zona di colonizzazione agraria…più volte Mussolini aveva fatto grandi promesse alla Sardegna e aveva pure stanziato un miliardo da rateare in dieci anni. Era stato tutto fumo, anche perché né i ras né i gerarchi e i deputati isolani osarono chiedergli fede alle promesse”.
Che si continui dunque nella celebrazione del 25 Aprile come Festa della Liberazione, ma soprattutto come momento e occasione di studio, di discussione sul nostro passato che non possiamo né rimuovere, né recidere né dimenticare.
Dobbiamo anzi disseppellirlo, non per riproporre vecchie divisioni e steccati ormai anacronistici e superati ma per creare concordia e unità: però nella chiarezza: evitando dunque il pericolo e il rischio, corso spesso negli anni, di ridurre il 25 aprile a rito unanimistico o, peggio, a semplice liturgia celebrativa. Magari accompagnato dal tricolore e dall’orrendo bolso e vieto Inno guerresco di Fratelli d’Italia.
Neredide Rudas
l’Isola dei coralli
e l’Identità sarda.
di Francesco Casula
Il corallo, quella preziosa arborescenza di cui la Sardegna è ricca e che anziché espandersi all’esterno si ramifica nelle profondità marine, metaforicamente rappresenta per Nereide Rudas la storia e l’identità dell’Isola: un’identità lacerata e fessurata. Ciò perché, come Sardi, storicamente, abbiamo sempre avuto un rapporto problematico con la realtà, una non conciliazione con il mondo. Di qui l’insicurezza e la sofferenza, frutto anche degli imperativi che ci hanno imposto dall’esterno i dominatori che si sono via via alternati nell’Isola: imperativi drammaticamente azzeranti, repressivi e nullificanti.
L’Identità di cui parla Nereide Rudas nel saggio non è analizzata però secondo le modalità della sociologia o dell’antropologia, ma secondo l’ottica specifica dell’attenzione psichiatrica: un’identità scissa, vissuta come problema, dentro i labirinti della sofferenza e dei tormenti, non come tranquilla modalità di essere nel mondo: quella sofferenza che ha segnato l’esistenza individuale e collettiva dei sardi.
Un’identità di cui l’autrice – più che cogliere l’essenza – s’interroga sul corpo dei significati che vogliamo esprimere con essa. Un’Identità dinamica, come percorso e progetto, non data e definita una volta per tutte, il che non significa che non ci sia qualcosa di stabile. Un’identità individuale ma che affonda in un corpo sociale, che invera quella dei singoli e la fa diventare concreta.
Un’identità che nei romanzieri e scrittori sardi – in Deledda come in Lussu, in Giuseppe Dessì e Salvatore Satta come in Salvatore Cambosu e Francesco Masala – è così forte che la Sardegna non è un semplice scenario, uno sfondo, ma la vera protagonista, non un luogo ma il luogo, non l’oggetto ma il soggetto.
Colpisce nel saggio di Nereide, pur in presenza di analisi di tipo psichiatrico e psicanalitico, la cifra della scrittura, la levità e il nitore del linguaggio, la suggestione della sua prosa, che affascina, che incanta e che cattura.
Certo per Nereide Rudas la memoria di noi sardi come una preziosa arborescenza di corallo, anziché ergersi e dilatarsi nell’aria si è inabissata nel nostro mare interno. Invece di espandersi e svilupparsi nel di-fuori, si è sommersa ed estesa nel di-dentro: ma, indovandosi, è diventata tenace e labirintica.
Certo, siamo un’Isola con sacche di arretratezza e di infelicità e non abbiamo ancora metabolizzato il nostro lutto, ma abbiamo grandi possibilità. Per la Sardegna si profila un orizzonte più felice e prospero se sapremmo coltivare e mettere a frutto i coralli nascosti. Bisogna però, secondo l’autrice, impegnarsi in un grande sforzo collettivo, in un serio, profondo e rigoroso progetto culturale. E conclude: allora la misteriosa “creatività” dei sardi di cui ho tentato di illuminare la faccia nascosta, si potrà dispiegare più potente e libera.
GLI ASSASSI NI DI SA DIE
E L’IGNORANZA.
ORA CI SI METTE ANCHE LA STAMPA
di Francesco Casula
Sono molti i becchini di Sa Die de sa Sardigna. Le istituzioni regionali e i Partiti in primis. Ora ci si mette anche la Stampa: in un quotidiano on line Cagliari-Casteddu, leggo che sarebbe “una inutile festa”.
Mi auguro che sia semplice ignoranza: ovvero che non conoscono (o non hanno capito):
1. Il significato storico.
Intanto occorre chiarire che non si è trattato di “robetta”: magari di una semplice congiura ordita da un manipolo di borghesi giacobini, illuminati e illuministi, per cacciare qualche centinaio di piemontesi: come pure è stato scritto. A questa tesi, del resto ha risposto, con dovizia di dati, documenti e argomentazioni Girolamo Sotgiu. Non sospettabile di simpatie “nazionalitarie” il prestigioso storico sardo, gran conoscitore e studioso della Sardegna sabauda, polemizza garbatamente ma decisamente proprio con l’interpretazione data da storici filo sabaudi, come il Manno o l’Angius al 28 aprile, considerato alla stregua, appunto, di una congiura. “Simile interpretazione offusca – scrive Sotgiu – le componenti politiche e sociali e, bisogna aggiungere senza temere di usare questa parola «nazionali».
“Insistere sulla congiura – cito sempre lo storico sardo – potrebbe alimentare l’opinione sbagliata che l’insurrezione sia stato il risultato di un intrigo ordito da un gruppo di ambiziosi, i quali stimolati dagli errori del governo e dalle sollecitazioni che venivano dalla Francia, cercò di trascinare il popolo su un terreno che non era suo naturale”,
A parere di Sotgiu questo modo di concepire una vicenda complessa e ricca di suggestioni, non consente di cogliere il reale sviluppo dello scontro sociale e politico
né di comprendere la carica rivoluzionaria che animava larghi strati della popolazione
di Cagliari e dell’Isola nel momento in cui insorge contro coloro che avevano dominato da oltre 70 anni. Non fu quindi congiura o improvviso ribellismo: ad annotarlo è anche Tommaso Napoli, padre scolopio, vivace e popolaresco scrittore ma anche attento e attendibile testimone, che visse quelli avvenimenti in prima persona. Secondo il Napoli “l’avversione della «Nazione Sarda» – la chiama proprio così – contro i Piemontesi, cominciò da più di mezzo secolo, allorché cominciarono a riservare a sé tutti gli impieghi lucrosi, a violare i privilegi antichissimi concessi ai Sardi dai re d’Aragona, a promuovere alle migliori mitre soggetti di loro nazione, lasciando ai nazionali solo i vescovadi di Ales, Bosa e Castelsardo, ossia Ampurias. L’arroganza e lo sprezzo – continua – con cui i Piemontesi trattavano i Sardi chiamandoli pezzenti, lordi, vigliacchi e altri simili irritanti epiteti e soprattutto l’usuale intercalare di Sardi molenti, vale a dire asinacci, inaspriva giornalmente gli animi e a poco a poco li alienava da questa nazione”.
2. Il significato simbolico.
I Sardi dopo secoli di rassegnazione, di abitudine a curvare la schiena, di acquiescenza, di obbedienza, di asservimento e di inerzia, per troppo tempo usi a piegare il capo, subendo ogni genere di soprusi, umiliazioni, sfruttamento e sberleffi, con un moto di orgoglio nazionale e un colpo di reni, di dignità e di fierezza, si ribellano e alzano il capo, raddrizzano la schiena e dicono: basta! In nome dell’autonomia e dunque, per “essi meris in domu nostra”. E cacciano Piemontesi (con Nizzardi e Savoiardi), non per motivi etnici, ma perché rappresentano l’arroganza, la prepotenza e il potere. Sono infatti militari, funzionari, impiegati. Cagliari all’alba dell’800 contava 20.000 abitanti, la burocrazia e il potere piemontese 514 esponenti: più di uno per ogni 40 cagliaritani!
Al di là comunque di tutto questo e dello specifico avvenimento, quello che è importante oggi nella Festa di Sa Die de sa Sardigna è proprio il suo il valore simbolico di autocoscienza storica e di forza unificante. Sia ben chiaro: nessun ripiegamento nostalgico o risentito verso il passato: ma il passato sepolto, nascosto, rimosso, si tratta prima di tutto di dissotterrarlo e conoscerlo, perché diventi fatto nuovo che interroga l’esperienza del tempo attuale, per affrontare il presente nella sua drammatica attualità, per definire un orizzonte di senso, per situarci e per abitare, aperti al suo respiro il mondo, lottando contro il tempo della dimenticanza; quel mondo grande e terribile di cui parlava Gramsci.

SA DIE DE SA SARDIGNA
di Francesco Casula
Pro amentare sa dispidida de sos Piemontesos est nàschida ”Sa Die, giornata del popolo sardo” – ma deo prefèrgio a li nàrrere “Festa natzionale de sos Sardos” – cun sa lege n.44 de su 14 Cabudanni de su 1993. Cun issa sa Regione Autònoma de sa Sardigna at chertu istituire una die de su pòpulu sardu, de tzelebrare su 28 de Abrile de cada annu, in ammentu – fia narende- de sa rebellìa populare de su 28 de Abrile de su 1794, est a nàrrere de sos “Vespri sardi” chi nch’ant giutu a s’espulsione dae Casteddu e dae s’Isula de sos Piemontesos e de àteros istràngios fideles a sa corte sabauda, inclùdidu su Vitzeré Balbiano chi nemos podiat bìdere.
Su problema chi oe tenimus in dae in antis, a livellu mescamente culturale, no est tantu su de torrare a pònnere in discussione sa data o, peus, su balore matessi de una “Festa natzionale sarda”, ma de non nche la torrare a unu ritu ebìa, a una vacàntzia iscolàstica ebia o a un’eventu petzi folclòricu e de festa.
Su problema est su de la cambiare in un’ocasione de istùdiu – mescamente in sas iscolas – de s’istòria e de sa cultura sarda, de cunfrontu e de discussione collettiva e populare, pro cumprèndere su chi semus istados, su chi semus e cherimus èssere; pro difèndere e isvilupare s’identidade nostra e sa cussèntzia nostra de pòpulu e de natzione; pro gherrare pro una Comunidade moderna e soverana, chi siat bona a pònnere in campu s’orgògliu e su protagonismu de sos Sardos, detzisos, in fines, a otènnere unu riscatu, o siat unu tempus benidore de ditzosidade e de bonistare, lassende•si in palas sa rassignatzione, sas lamentas, sos prantos e sos cumplessos de inferioridade e aende s’ànimu de “nche bogare” sos “Piemontesos noos” o romanos o milanesos chi siant, non prus pagu barrosos, prepotentes isfrutadores e “tirannos” de cussos dispididos dae Casteddu su 28 de Abrile de su 1794.
“Fu un momento esaltante – at iscritu Giovanni Lilliu – fu un’azione, poi bloccata dalla reazione “realista”, tesa a procurare un salto di qualità storica. Fu il tentativo di ottenere il passaggio da una Sardegna asservita al feudalesimo ad una Sardegna libera, fondando nell’autonomia, nel riscatto della coscienza e dell’identità di popolo una nuova patria sarda, una nazione protagonista”.
Semper e cando, lassende a un’ala totu custu e s’eventu particulare, su chi contat oe est su balore simbòlicu de autocussèntzia istòrica e de fortza unificante. Perunu torròngiu in palas nostàlgicu o risentidu cara a su tempus coladu, duncas: ma su tempus coladu sepultadu, cuadu, rimòvidu, si tratat, in antis de totu, de nche lu tirare dae suta de terra e de lu connòschere, a manera chi diventet fatu nou chi intèrrogat s’esperièntzia de su tempus atuale, pro pònnere fronte a su tempus presente in s’atualidade drammàtica sua, pro definire un’orizonte de sensu, pro nos situare e pro abitare, abertos a s’alenu suo, su mundu, gherrende contra a su tempus de s’ismèntigu. Unu tempus coladu chi – pèrdidu petzi in aparièntzia – tocat de l’agatare ca est durada, eredidade, cussèntzia. In issu, infatis, si inferchit su balore de s’’Identidade, no istàticu e tancadu, non memòria cristallizada ma patrimòniu chi benit dae largu e fundamentu in ue fàghere falare aportos noos de culturas, de bidas individuales e sotziales chi determinant semper identidades noas
Su messàgiu de Sa die est diretu mescamente a sos giòvanos e s’ocasione istòrico-culturale est destinada in antis de totu a sos istudentes, pro chi otèngiant sa cunsapevolesa de apartènnere a un’istòria e a una tzivilidade e de ereditare unu patrimòniu culturale, linguìsticu, artìsticu e musicale, ricu de siendas de elaborare e cunfrontare cun esperièntzias e propostas de unu mundu prus mannu e cumplessu. In ue, moende dae raighinas seguras e frunidos de alas fortes, potzant bolare in artu: sos giòvanos e non solu .

