I tiranni sabaudi
5° Carlo Felice (1821-1831)
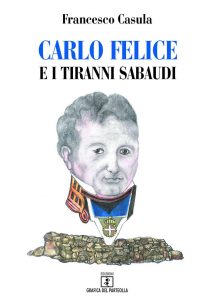
Carlo Felice fu il peggiore fra i sovrani sabaudi, da vicerè come da re fu crudele e feroce (in lingua sarda incainadu), famelico, gaudente e ottuso (in lingua sarda tostorrudu). E ancora: Più ottuso e reazionario d’ogni altro principe1, oltre che dappocco, gaudente parassita, gretto come la sua amministrazione2, lo definisce lo storico sardo Raimondo Carta Raspi. Mentre per un altro storico sardo contemporaneo, Aldo Accardo, – che si basa sulle valutazioni di Pietro Martini – è Un pigro imbecille3.
- Crudele e feroce, despota e sanguinario.
Sarà soprannominato Carlo Feroce dai liberali piemontesi e da Angelo Brofferio astigiano, (poeta, e critico teatrale) nonché patriota (anche lui perseguitato e arrestato in Piemonte nel 1830, regnante Carlo Felice) e che nel 1854 verrà eletto deputato a Cagliari, per protesta contro Cavour.
La repressione violenta la esercita delegandola al famigerato Giuseppe Valentino, soprattutto nei confronti dei democratici, come nel caso di Vincenzo Sulis, il capopolo della rivolta cagliaritana contro i Piemontesi nel 1794, spesso “inventando” congiure inesistenti, e prezzolando i delatori. Ecco come lo descrive Pietro Martini, il fondatore della storiografia sarda, pur filo monarchico e filo sabaudo:
”Non sì tosto il governo passò in mani del duca del Genevese, la reazione levò più che per lo innanzi la testa; cosicché i mesi che seguirono furono tempo di diffidenza, di allarme, di terrore pubblico. A raffermare l’ordine si pronunciava necessaria la dispersione degli uomini più famosi negli ultimi moti popolari, ai quali Sulis avea soprastato. Ma come per artigliarli faceva mestieri di accreditare una congiura con grandi ramificazioni e con un capo, i delatori prezzolati dal comando della piazza e gli avidi di vendetta la immaginarono. e ne denunciarono, capo il Sulis, membri i di lui satelliti antichi, i famigerati per animo turbolento, i giacobini4.
E Raimondo Carta Raspi, a conferma di quanto sostenuto dal Martini scrive:”Ai feudatari, da viceré, diede carta bianca per dissanguare i vassalli. Mentre a personaggi come Giuseppe Valentino affidò il governo: questi svolse il suo compito ricorrendo al terrore, innalzando forche soprattutto contro i seguaci di Giovanni Maria Angioy, tanto da meritarsi, da parte di Giovanni Siotto-Pintor, l’epiteto di carnefice e giudice dei suoi concittadini.” Sempre il Carta Raspi aggiunge a tal proposito: “Rivalutandone il governo si è perfino voluto attribuire a Carlo Felice il merito di aver restaurato l’autorità regia, che avrebbe barcollato durante i regni del padre e del fratello maggiore. Appare invece tutto il contrario, se già non si vuole scambiare terrore con prestigio, autorità con forche. «Non si tosto il governo passò in mani del duca del Genovese – scrisse il Martini – la reazione levò più che per lo innanzi la testa; cosicché i mesi che seguirono furono tempi di diffidenza, di allarme, di terrore pubblico.» L’autorità e il prestigio del regio governo erano stati affidati al Valentino, cui si aggiunse il Villamarina, e a tutti gli elementi reazionari degli stamenti.
Governo poliziesco per una parte, per altra letargico. Se così non fosse stato, anziché peggiorare le condizioni dell’isola avrebbero dovuto progredire, e intendiamo soprattutto in senso economico, poiché serve a ben poco riformare qualche norma giuridica a una popolazione oppressa ed affamata. Non che favorire lo sviluppo dell’agricoltura e valorizzare le molteplici risorse dell’isola, Carlo Felice aveva dato carta bianca ai feudatari per dissanguare i vassalli, ciò che doveva inevitabilmente produrre tutto l’opposto, disamorando i contadini dalla terra che dovevano lavorare senza incentivi, come bestie e strumenti padronali”5 .
- Famelico
Scrive il Martini a questo proposito:“Per la morte del conte di Mariana, il donativo di scudi sessanta mila rimase intiero al duca del Genevese. Onde portare sicuro giudizio di quest’atto giova rammentare il donativo di cento cinquanta mila scudi offerto dagli stamenti a re Carlo Emanuele nel 1799, e la distribuzione da lui fattane ai principi di sua famiglia: giova aggiungere che il re, stante la breve sua permanenza nel regno, una parte soltanto ne riscosse e che gli stamenti, perché col restare nell’isola i soli due principi, il duca del Genevese ed il conte di Moriana, mutate erano le circostanze consigliatrici di quell’egregio donativo, questo abolito, un nuovo ne votarono per ambidue nella somma di scudi sessanta mila.
I due’ principi sel ripartirono in guisa che se ne tolse scudi trentacinque mila il duca del Genevese, e venticinque mila il conte di Moriana. Ondeché, alla morte di costui, la sua rata doveva cessare a sgravio dei regnicoli, od almeno si sarebbe dovuta devolvere alla oberata finanza. E pure, consenzienti o tolleranti gli stamenti, Carlo Felice se l’appropriò, tanto più illegittimamente, che traeva pure dall’erario gli utili della carica viceregale7.
- Gaudente, ottuso e incapace.
Cito sempre Pietro Martini che scrive “Inclinato ai diletti delle campagne ridenti, agli spettacoli del teatro, ai piacevoli trattenimenti, ai lauti prandi, abborrì dalle cure che affaticandogli la mente gli turbassero per poco il lieto suo vivere. Non ambì dunque l’imperio, e se lo tenne prima come viceré, indi come re, fu perché il credette un debito verso la dinastia, i popoli suoi ed anche l’Europa, che la pace faceva dipendere dal principio della legittimità monarchica. Animo aveva di felicitare gli stati suoi, ma non virtù di reggerli da per sé; ché gli veniva meno ogni esperienza di pubblici negozi, ogni vera cognizione dell’età in cui viveva, e poca coltura avea di lettere. Informato alla giustizia, quando credeva di ottemperarvi era così inesorabile, che pareva d’animo feroce a chi non aveva appreso quanto buono avesse il cuore, e di qual tempera fosse quella carità e generosità che alle moltitudini sarde velavano i difetti del governante supremo. Tale costanza poi aveva nei propositi, che soventi più che fermo di carattere, ostinato si appalesava. Un principe così fatto doveva per necessità diventare, tranne per le cose più gravi, studiate e decise nel suo secreto, servo dei ministri, ma più dei cortigiani”8.
Secondo Raimondo Carta Raspi, Carlo Felice, negato alla politica e a ogni manifestazione intellettuale, preferì gli ozi e gli svaghi della Villa Orrì.
E ancora, sempre il Martini scrive: ”Per indole al comando e alle pubbliche cure preferiva i placidi ozi del vivere privato e tranquillo, e sovra tutto il delizioso stare nel podere di Villahermosa, la Villa d’Orri”9 . A gozzovigliare e mangiare porchetti arrosto, come abbiamo visto documentato da Raimondo Carta Raspi. Mentre a Cagliari e in Sardegna la popolazione moriva di fame e i bambini di vaiuolo.
Tutto ciò sia da viceré che da re.
Anzi, divenuto re con l’abdicazione del fratello Vittorio Emanuele I, diventa viepiù famelico, crudele e reazionario: “divenuto re – scrive Carta Raspi – doveva mostrarsi più ottuso e reazionario di ogni altro principe”9 , e “Nei consigli del principe prevaleva il principio del terrore e dell’arbitrio senza limiti”11.
Mira a conservare e restaurare in Sardegna lo stato di brutale sfruttamento e di spaventosa arretratezza. Uso ancora l’affilata prosa di Carta Raspi: “In Sardegna, poiché la rivoluzione francese non l’aveva neppure sfiorata, non vi fu nulla da modificare e nulla mutò neppure in seguito, anche per l’assenza di moti liberali, stratificando ancor più lo stato di privilegi e miserie, di sfruttamento e di arretratezza.
Bene se ne rese conto il Martini, che quasi a conclusione della sua pregevole monografia scriveva:”La reazione oltremarina era una guarentigia del durare dell’isola con le grandi piaghe spagnole, e quindi con le decime, coi feudi, coi privilegi, col foro clericale, col dispotismo viceregio, con l’iniquo sistema tributario, col terribile potere economico e coll’enorme codazzo degli abusi, delle ingiustizie, delle ineguaglianze e delle oppressioni intrinseche ad ordini di governo nati nel medioevo”12.
Pur ottuso e incapace, Carlo Felice doveva conoscere le condizioni economiche e finanziarie drammatiche della Sardegna, nonostante ciò si accanisce con un fiscalismo esasperato, ecco cosa scrive in un biglietto viceregio del marzo 1804, aprossimandosi la riunione dei tre ordini:”Premesso un quadro lamentevole condizioni della finanza, ne dimostrò l’origine nella guerra lunga e dispendiosa; nella perdita degli stati regi continentali; nel quasi annientato commercio dell’isola; nella straordinaria sterilità dei feraci suoi terreni; nelle maggiori spese per le provvisioni di vettovaglie, vestimenta, foraggi ed arnesi di caserma per le truppe, che prima si facevano a prezzi più bassi; nei dispendi a dismisura cresciuti per lo mantenimento della tranquillità interna, per la difesa delle marine e segnatamente dai Barbareschi, per l’amministrazione della giustizia; e soprattutto nel mancato ramo di rendita proveniente dalla esportazione dei cereali. E poiché accennava ai clamori dei pubblici officiali e dei lavoranti in opere dello stato non pagati, ed al pericolo d’un prossimo sfasciamento totale della pubblica amministrazione, considerando come fosse di somma urgenza un sussidio al tesoro, non minore di quattrocento mila lire sarde, conchiuse col raccomandarsi agli stamenti, onde vi supplissero con un tributo straordinario”13.
Gli è che Carlo Felice odia i sardi: il suo maestro, in tal senso è il reazionario Giuseppe de Maistre che arrivato in Sardegna nel 1800 per reggere la reale cancelleria, non pensa nei tre anni di reggenza, che ai propri interessi denotando uno sviscerato disprezzo per la Sardegna :un paese maledetto14 e per i Sardi : je ne connais rien dans l’univers au-dessous (sotto) des molentes, soleva affermare nei loro confronti. E in una lettera da Pietroburgo al Ministro Rossi nel 1805 scrive :”Le sarde est plus savage che le savage , car le savage ne connait la lumiere e le Sarde la connait”15.
Note Bibliografiche
- Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, Ed. Mursia, Milano, 1971, pagina 854
- Ibidem, pagina 848.
- Pietro Martini, Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816, a cura di Aldo Accardo, Ilisso Edizioni,1999, pagina 27.
- 4. Ibidem, pagine 79-80.
5 Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, op. cit. pagina 849.
- Pietro Martini, Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816, op. cit., pagine, 128-129.
- Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, op. cit. pagina 848-849
- Pietro Martini, Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816, op. cit. pagina 78.
- Ibidem, pagine 158-159
10.Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, op. cit. pagina 854.
11 Pietro Martini, Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816, op. cit. pagina 137
- Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, op. cit. pagina pagina 854.
- Pietro Martini, Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816, op. cit. pagina 141.
- . Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, op. cit. pagina 892.


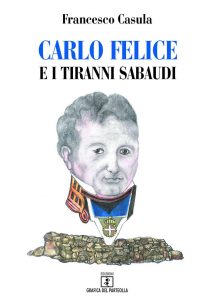


 Vi sono poi innumerevoli vocaboli tipicamente sardi e solamente sardi che Deledda inserisce nelle sue opere quando attengono all’ambiente sardo: pensiamo a tanca (terreno di campagna chiuso da un recinto fatto in genere di sassi), socronza, usatissima in Elias Portolu (consuocera), corbula (cesta), bertula (bisaccia), tasca (tascapane), leppa (coltello a serramanico), cumbessias o muristenes (stanzette tipiche delle chiese di campagna un tempo utilizzate per chi dormiva là per le novene della Madonna o di Santi), domos de janas (tombe rupestri e letteralmente “case delle fate”). O addirittura intere frasi in sardo come: frate meu (fratello mio), Santu Franziscu bellu (San Francesco bello), su bellu mannu (il bellissimo, letteralmente il bello grande), su cusinu mizadu (il borghese con calze), a ti paret? (ti sembra?), corfu ‘e mazza a conca (colpo di mazza in testa), ancu non ch’essas prus (che tu non ne esca più: è un’imprecazione). Qualche volta Deledda ricorre a frasi italiane storpiate in sardo o frasi sarde storpiate in italiano: Come ho ammaccato questo cristiano così ammaccherò te (…) o Avete compriso?”.
Vi sono poi innumerevoli vocaboli tipicamente sardi e solamente sardi che Deledda inserisce nelle sue opere quando attengono all’ambiente sardo: pensiamo a tanca (terreno di campagna chiuso da un recinto fatto in genere di sassi), socronza, usatissima in Elias Portolu (consuocera), corbula (cesta), bertula (bisaccia), tasca (tascapane), leppa (coltello a serramanico), cumbessias o muristenes (stanzette tipiche delle chiese di campagna un tempo utilizzate per chi dormiva là per le novene della Madonna o di Santi), domos de janas (tombe rupestri e letteralmente “case delle fate”). O addirittura intere frasi in sardo come: frate meu (fratello mio), Santu Franziscu bellu (San Francesco bello), su bellu mannu (il bellissimo, letteralmente il bello grande), su cusinu mizadu (il borghese con calze), a ti paret? (ti sembra?), corfu ‘e mazza a conca (colpo di mazza in testa), ancu non ch’essas prus (che tu non ne esca più: è un’imprecazione). Qualche volta Deledda ricorre a frasi italiane storpiate in sardo o frasi sarde storpiate in italiano: Come ho ammaccato questo cristiano così ammaccherò te (…) o Avete compriso?”.
